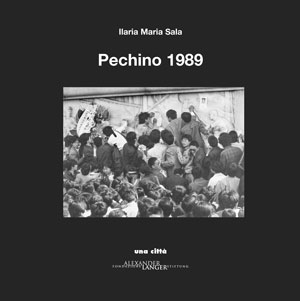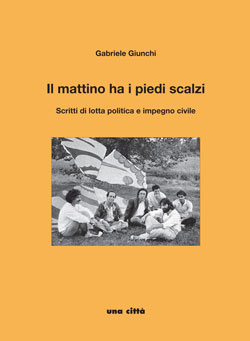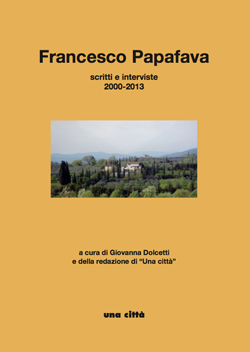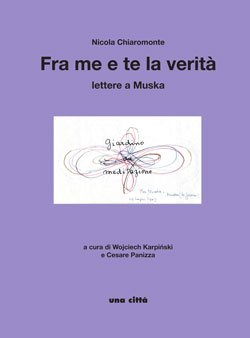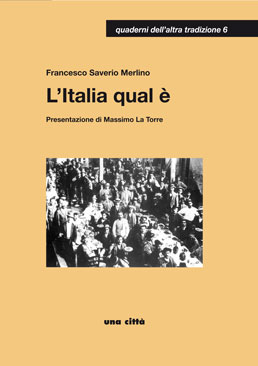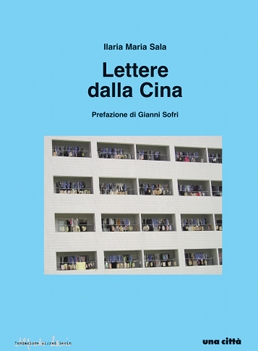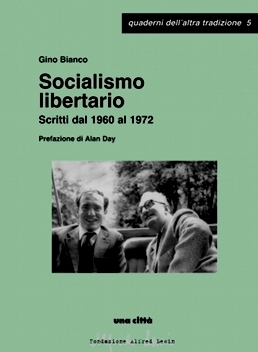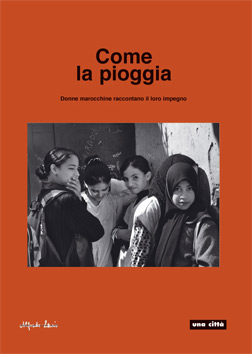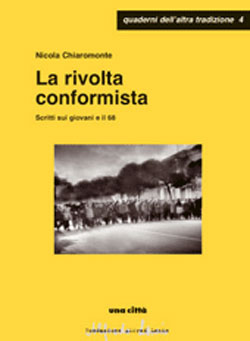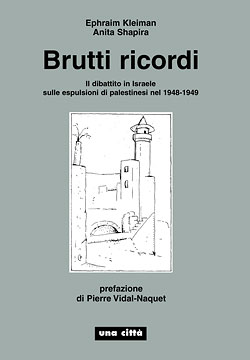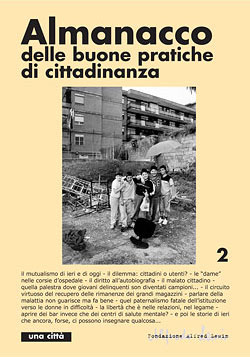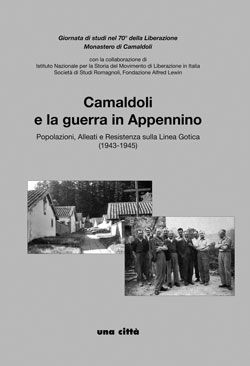Le analogie storiche non calzano mai perfettamente: il 2025 non è certo il 1938. La data a noi più prossima ha segnato il tentativo di imporre una pace sulla guerra russo-ucraina, mentre quella più distante era stata contraddistinta dal tentativo di impedire una guerra tra la Germania e le democrazie europee. Eppure la conferenza stampa del 28 febbraio scorso, tenuta dal presidente Usa Donald Trump e dal suo vice JD Vance con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ci ha fatto riaffiorare alla mente ricordi spiacevoli. Questo “affare”, con cui si porrebbe fine al conflitto a costo dell’integrità della sovranità ucraina, assomiglia molto a quegli accordi di Monaco del 1938 con cui si cercava di mettere pace tra la Germania e le democrazie europee a costo dell’abbandono della Cecoslovacchia al proprio infausto destino.
Dopo aver ritirato la Germania dalla Società delle Nazioni, messo fine all’occupazione francese del protettorato della Saar, rimilitarizzato la Renania e ottenuto l’annessione (Anschluss) dell’Austria, Adolf Hitler aveva rivendicato i Sudeti, quell’area della Cecoslovacchia abitata da cittadini di discendenza germanica, e minacciato di dichiarare guerra qualora le sue richieste non fossero state esaudite. Accontentarlo avrebbe significato lo smembramento della Cecoslovacchia, motivo per cui il suo presidente, Eduard Benes, vi si era opposto. In termini pratici, la resistenza ceca dipendeva dal sostegno dei suoi alleati democratici, l’Inghilterra e la Francia.
L’Europa sembrava di nuovo sull’orlo di una catastrofe, appena vent’anni dopo la fine della Prima guerra mondiale, terminata nel 1918. Disposto a evitare la guerra a ogni costo, il primo ministro britannico Neville Chamberlain e quello francese Edouard Daladier si erano accordati con Benito Mussolini, che all’epoca sembrava ambivalente riguardo alle ambizioni imperialiste del suo alleato, ed era andato a Monaco per incontrare Hitler. In particolare, è il comportamento del Fuhrer con Chamberlain a richiamare quello tenuto da Trump e Vance con Zelensky. In quell’occasione Hitler aveva fatto una sfuriata, incutendo il timore di Dio nei capi delle principali democrazie d’Europa. Tutto questo, però, era successo a porte chiuse, mentre le sparate del presidente Trump e di JD Vance sono avvenute in pubblico, davanti a tutto il mondo.
Non che ciò li abbia messi in imbarazzo. Il comportamento infantile di Trump non gli è certo costato il supporto della sua base; checché si voglia dire del presidente, una cosa è certa: conosce il suo pubblico. A Zelensky non restava altra scelta che accettare l’invito di apparire davanti alle telecamere per discutere una pace che non aspettava altro che la sua approvazione. Eppure, questa non era sufficiente: Trump e Vance volevano mostrarlo prostrarsi davanti al mondo per ringraziare la Casa Bianca per un’iniziativa politica che si sarebbe dimostrata svantaggiosa per il suo paese. Tutto l’incontro altro non era che il set perfetto per esibire quel tipo di retorica da bulli che Trump in particolare è solito adoperare.
La sovranità Ucraina era già compromessa; questo, infatti, era stato il prezzo da pagare per l’aiuto già ricevuto dall’amministrazione Biden per respingere l’invasione russa. In una simile condizione di dipendenza, Zelensky era già in posizione di netta inferiorità. Lo sapeva lui, e lo sapevano bene anche i leader Usa.
Peraltro, Trump è da tempo un ammiratore del presidente russo, e sono ben noti i suoi loschi affari immobiliari con Mosca, come è risaputa la sua antipatia per Zelensky, risalente al rifiuto di quest’ultimo di falsificare delle prove sul figlio dell’allora vice-presidente Biden che gli potevano tornare utili nel corso della campagna presidenziale del 2020.
La parola “appeasement”, pronunciata oggi, ha un sapore nuovo. Con quell’approccio, Chamberlain e Daladier volevano soddisfare la fame imperialista del nemico, Hitler, mentre ora Trump vuole solo normalizzare i rapporti con la Russia per fare un favore all’amico Putin. Quando insisteva nel dire in campagna elettorale che avrebbe potuto porre fine alla guerra “in 24 ore”, Trump si dimostrava già pronto a esaudire la volontà di Putin di appropriarsi di circa il 20% dell’Ucraina. Proprio come la Cecoslovacchia nel 1938, dunque, nel 2025 l’Ucraina rischia di finire smembrata, però c’è una differenza: Chamberlain sperava con tutto il cuore che Hitler non avanzasse ulteriori richieste territoriali e rispettasse ciò che rimaneva della Cecoslovacchia, mentre Trump pare cinicamente disinteressato all’eventualità che Putin rinunci o meno a ulteriori avventure imperialiste.
L’accordo tra Trump e Putin, a quanto pare, era in preparazione ben prima della famosa conferenza stampa con Zelensky. L’avevano delineato Stati Uniti e Russia a Riad, in Arabia Saudita, per mano del Segretario di Stato americano Marco Rubio e del Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Si era trattato di un vertice isolato e, proprio come dalla Conferenza di Monaco del 1938 erano state escluse la Cecoslovacchia e gli altri stati est-europei, a Riad non sono stati invitati né rappresentanti dell’Ucraina né dell’Unione europea. Questo non può sorprendere nessuno, date le basi su cui questa pace si sarebbe dovuta concludere, e cioè quello che Trump stesso, orgogliosamente, ha definito “un grandissimo affare” capace di dare agli Stati Uniti accesso pressoché illimitato alle riserve minerarie inutilizzate dell’Ucraina in cambio di un “fondo di investimento per la ricostruzione” gestito congiuntamente da Kiev e Washington.
Non è stato reso pubblico un eventuale ruolo previsto in quest’impresa per le società di Trump, ma state pur certi che alla fine il presidente otterrà la sua fetta di torta. Trump punta molto sul fatto che l’accordo ricompenserà gli Stati Uniti con 500 miliardi di dollari di profitti a fronte dei 130 miliardi di aiuti (e non 350, come dichiarato dal presidente) forniti fin qui all’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione russa.
L’appeasement odierno presenta un ulteriore differenza con il passato: non solo prevede l’abbandono a se stesso di un alleato e il rafforzamento di un dittatore, ma costringe anche la vittima dell’invasione a pagare un prezzo di cui beneficerà l’invasore.
Questa forma di “compensazione” mineraria dovrebbe partire immediatamente, mentre i soldi americani arriverebbero dopo -non proprio la formula ideale per una gestione “congiunta” del fondo di investimento per la ricostruzione.
Senza ulteriori garanzie sulla sicurezza ucraina, inoltre, l’idea che un simile accordo possa essere sufficiente a stemperare le ambizioni imperialiste di Putin appare quantomeno ingenua, se non addirittura un escamotage per nascondere le vere intenzioni -e propendo per l’ultima opzione, dato che Trump ha spesso affermato che intende lasciare carta bianca a Putin sulla regione e mira a normalizzare i rapporti col vecchio nemico della Guerra fredda.
A essere generosi, si può anche pensare che Chamberlain conoscesse i rischi della guerra e con la sua manovra diplomatica stesse solo prendendo tempo per permettere a Inghilterra e Francia di cominciare il riarmo. Ma certo non si può dire lo stesso di Trump con Putin. Gli Stati Uniti hanno cambiato rotta a tutta la loro politica estera, e in questa terribile guerra tra russi e ucraini hanno decisamente cambiato lato della barricata. Proprio ora che Trump lo ha definito “un dittatore”, c’era da aspettarsi che Zelensky protestasse circa il trattamento ricevuto in mondovisione e mettesse in dubbio questo accordo. Ma è altrettanto vero che il fatto che la sua amministrazione non avesse un piano B a sostegno di questa protesta è indice di irresponsabilità -e lo stesso può essere detto dell’Unione europea.
I paesi europei si trovano ora nella stessa posizione dell’amministrazione Biden, e cioè ci si aspetta che offrano un appoggio (illimitato) all’Ucraina. L’Ue potrebbe anche comprare il sostegno di uno o due paesi, come l’India o persino la Cina, perché entrino nell’alleanza. Certo è, però, che ora sta all’Europa prendere la guida della difesa dell’Ucraina e della resistenza all’imperialismo russo. Resta da capire se questo comporterà l’aumento degli aiuti militari, un aggravio delle sanzioni e del boicottaggio di Mosca o persino la creazione di un esercito europeo.
Intanto, Turchia, Francia e Regno Unito parlano già di inviare truppe in Ucraina, cosa che accresce il rischio di un ampliamento del conflitto.
Il mondo si sta ancora riprendendo dalla débacle della conferenza stampa del 28 febbraio, e ancora non sappiamo se era stata preparata appositamente o frutto di provocazioni improvvisate da Trump e Vance. Dimostrando di saper tenere testa a dei bulli autoritari, Zelensky ha salvato la faccia, ma questi cercheranno sicuramente di fargliela pagare; Trump potrebbe anche invocare il ritiro delle sanzioni alla Russia, la loro applicazione all’Ucraina, o -come affermato durante lo scontro verbale- abbandonare del tutto Kiev e l’Europa a cavarsela con le proprie forze.
Proprio come la Cecoslovacchia del 1938, che era oggetto di un’aggressione imperialista, anche l’Ucraina del 2025 ha un’importanza secondaria in questa crisi tuttora in corso. Certo, sarebbe un grave errore presumere che, al presentarsi di una nuova crisi, il presidente Trump si comporterà seguendo quello che tradizionalmente intendiamo per “interesse nazionale”. Se lo avesse a cuore davvero, non applicherebbe certo dazi elevati alla Cina (su alcuni beni, fino al 25%), né sosterrebbe la Russia ignorando la minaccia che Putin rappresenta per la pace globale.
Le azioni descrivono la realtà meglio delle parole: Trump ha sempre fatto coincidere l’interesse nazionale con i benefici che possono arrivare per sé o i suoi affari. L’implicazione politica di questo approccio è che il presidente non segue alcuna strategia prestabilita, ma piuttosto il proprio opportunismo mascherato da tattica. Questo significa che non si possono più dare per certe le alleanze storiche, che è lecito aspettarsi esercizi arbitrari della forza, che in qualunque momento una politica può essere sovvertita e che nessuna nazione può più considerare gli Stati Uniti un alleato affidabile.
L’appeasement del 1938 portò al disastro. La scarsa risolutezza dimostrata da Chamberlain e Daladier spinse Mussolini a stringere il “patto d’acciaio” con i nazisti, rese Hitler più audace nell’imporre il suo volere sulla Polonia e spinse Stalin a riconsiderare la partecipazione comunista al Fronte popolare anti-fascista del 1936. Tre anni dopo, la Russia dovette invertire del tutto la rotta firmando il noto patto “di non aggressione” con Hilter, cosa che diede il la alla Seconda guerra mondiale. Cionondimeno, c’è un’altra differenza cruciale tra allora e oggi: Chamberlain e Daladier temevano Hitler e la guerra che avrebbe potuto provocare, mentre Trump non teme affatto Putin. Al contrario: gli Stati Uniti sono pronti a lasciare mano libera a Putin nella regione, cosa che potrebbe permettergli di prendere di mira gli stati baltici. Ma questo potrebbe anche mettere Zelensky sotto pressione, costringendo lui -o un suo successore- a tornare a Washington in ginocchio per accettare l’accordo originale. Cosa succederà ora è poco chiaro, in parte perché nessuna nazione democratica può più contare sugli Stati Uniti come alleati nella battaglia per difendere la libertà.
(traduzione di Stefano Ignone)
Da Chamberlain a Trump
cosa sta succedendo

Una Città n° 307 / 2025 febbraio
Articolo di Stephen Eric Bronner
Tradotto da Stefano Ignone
DA CHAMBERLAIN A TRUMP
Un presidente, quello americano, che antepone l’opportunismo alla strategia; le analogie e le differenze tra quest’iniziativa di pace per l’Ucraina e gli accordi di Monaco del 1938; il mondo che non può più contare sugli Usa come alleato affidabile... Di Stephen Eric Bronner.
Archivio
IL POTENZIALE DI CAMBIAMENTO
Una Città n° 166 / 2009 Giugno-Luglio
Realizzata da Barbara Bertoncin
Realizzata da Barbara Bertoncin
Stephen Bronner è senior editor di Logos, giornale online (www.logosjournal.com). Ha pubblicato, tra l’altro, Peace out of reach. Middle Eastern Travels and the Search for Reconciliation, The University Press of Kentucky 2007. Insegna Scienze Politiche al...
Leggi di più
LA SINISTRA PATRIOTTICA
Una Città n° 127 / 2005 Marzo
Realizzata da Barbara Bertoncin
Realizzata da Barbara Bertoncin
Stephen Eric Bronner è senior editor di Logos, giornale online (www.logosjournal.com). Recentemente ha pubblicato A Rumor about the Jews: Anti-Semitism, Conspiracy, and the Protocols of Zion, Oxford University Press, e Reclaiming the Enlightenment: Toward...
Leggi di più
L'ASSURDO
Una Città n° 232 / 2016 luglio-agosto
Realizzata da Sepher Solyman
Realizzata da Sepher Solyman
Pubblichiamo un’intervista a Stephen Eric Bronner apparsa sulla rivista letteraria iraniana "L’itrarcoria”.
Cominciamo con una domanda poco convenzionale: quanto consideri positiva, o negativa, la visione del mondo dell’ass...
Leggi di più
LA SUA IDEA DI LIBERTA'
Una Città n° 204 / 2013 Giugno-Luglio
Realizzata da Jason Shulman, traduzione di Maria Laura Morgione
Realizzata da Jason Shulman, traduzione di Maria Laura Morgione
Stephen Bronner è senior editor di Logos, giornale online (www.logosjournal.com). Insegna Scienze Politiche alla Rutgers University del New Jersey. Ha pubblicato, tra l’altro, Modernism at the Barricades: Aesthetics, Politics, Utopia (Columbia University ...
Leggi di più
LA DEMOCRAZIA NON E' FACILE
Una Città n° 195 / 2012 G
Realizzata da Barbara Bertoncin, traduzione di Andrea Furlanetto
Realizzata da Barbara Bertoncin, traduzione di Andrea Furlanetto
Stephen Bronner è senior editor di Logos, giornale online (www.logosjournal.com). Insegna Scienze Politiche alla Rutgers University del New Jersey.
Con la salita al potere di Bashar al-Assad, dodici anni fa, la comunità internazionale si...
Leggi di più