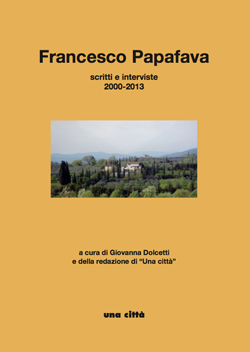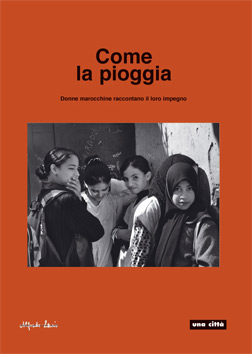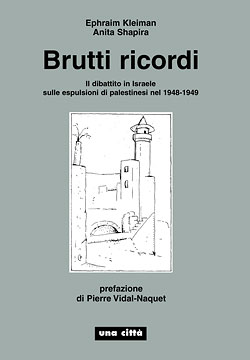Il commercio equo e solidale attraversa una fase di boom, eppure rappresenta solo una piccolissima parte del commercio internazionale: potrà mai raggiungere volumi significativi?
La crescita è stata davvero impetuosa, in Italia soprattutto. In pochi anni si è raggiunto un giro d’affari che si può stimare vicino ai 50 milioni di euro all’anno. Oggi le Botteghe del Mondo sono 450, mentre alcuni alimenti equosolidali, banane, cioccolato, caffè, tè, riso, succhi di frutta, miele e palloni, si vendono in 3500 punti vendita della grande distribuzione. 70.000 studenti consumano alcuni di questi prodotti nelle mense scolastiche, mentre aziende e università hanno sostituito i tradizionali dispencer di caffè e dolciumi con quelle fornite dal commercio equo. Una recente ricerca ha indicato che nel 2003 circa 7 milioni di italiani hanno fatto almeno un acquisto di questi prodotti e un milione si dichiara acquirente abituale. Se si pensa che appena una decina d’anni fa c’erano solo poche decine di Botteghe del Mondo piccole e quasi sconosciute, si ha già una misura di questa impennata. E’ vero che, nonostante tutto, a livello mondiale il commercio equo probabilmente non va oltre lo 0.01% degli scambi complessivi. Ma questo non deve confondere. Il suo significato è molto superiore al suo volume, basta riflettere su un punto. I sostenitori del sistema economico attuale, basato su mercato, concorrenza, privatizzazioni, sostengono che non esistono alternative praticabili. Eppure il commercio equo e solidale dimostra con trent’anni di esperienza in Europa e 5 milioni di famiglie di produttori del Sud del mondo, che i dogmi del Mercato Liberista possono benissimo essere disattesi e che un modello che si fonda su altri presupposti funziona. Il raggiungimento di volumi molto più grandi dipende soprattutto da due fattori: l’arrivo di nuove famiglie di prodotti sul mercato e l’ancor maggiore diffusione tramite la grande distribuzione. I tessili, i cosmetici, i mobili e i casalinghi sono le nuove frontiere, già in parte sperimentate. Quanto ai supermercati, è lo stesso movimento che “frena”: si teme che siano le scelte delle maxi catene commerciali a impadronirsi del commercio equo, inoltre la vendita dei prodotti equi a fianco di quelli sotto boicottaggio è ancora fieramente avversata da tanti volontari e militanti.
Chi conosce il commercio equo è abituato al caffè, al tè, al cioccolato. Prodotti di larga diffusione, ma non abbastanza da incidere sul grosso dei consumi delle famiglie. Perché i prodotti industriali sono rimasti fuori finora?
Non è un caso se le importazioni sono iniziate proprio con i beni cosiddetti coloniali. Per milioni di agricoltori e artigiani dei Paesi poveri sono ancora la base del loro sostentamento. Però i prezzi del caffè, del tè o del cacao, per fare un esempio, sono fissati sulle Borse internazionali e sono soprattutto il risultato delle scelte dei grandi gruppi transnazionali. Quando il prezzo crolla, come è accaduto per molti di questi beni negli ultimi anni, decine di milioni di famiglie precipitano nella disperazione. Ecco perché il commercio equo, come sostengono molti produttori, è l’unica possibilità di sopravvivenza. Tuttavia per tentare di incidere sulle regole del gioco del commercio internazionale, bisognerebbe misurarsi con prodotti di largo consumo, che sono il frutto di processi industriali. E qui nascono i problemi. Il primo è legato al fatto che tra i criteri che gli importatori del commercio equo chiedono ai produttori c’è quello di avere una struttura democratica. E infatti tante sono cooperative, piccoli gruppi o comunità di villaggio. Ma oggi c’è chi si accontenta di criteri meno rigidi pur di affrontare questo tema. Si può avere come interlocutore un’azienda, se questa si impegna a rispettare parametri economici, sociali e ambientali che sono quasi la normalità in Europa, ma in Asia o in America Latina rappresentano un grande passo avanti?
Sono nati con queste premesse i progetti che hanno portato in Europa i palloni e i jeans “etici”, presto arriveranno altre linee di abbigliamento. Un jeans o una scarpa sportiva prodotti senza lo sfruttamento dei lavoratori e venduti in Occidente con un marchio ben riconoscibile, sarebbero probabilmente un successo. Ma un controllo “etico” di tutta la filiera di un prodot ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!