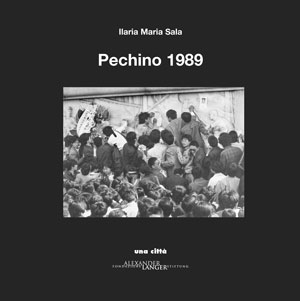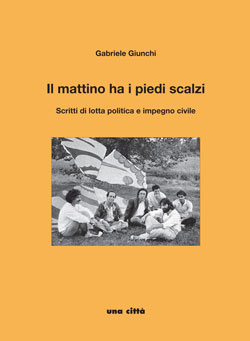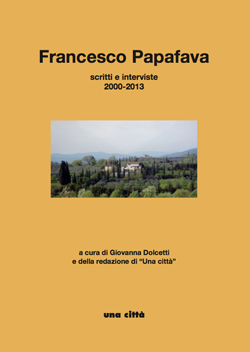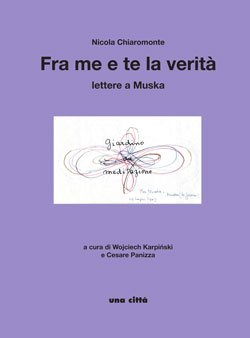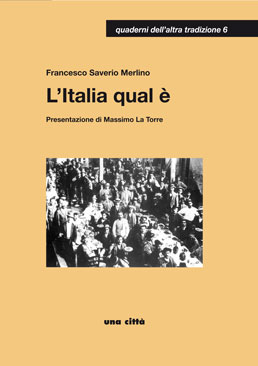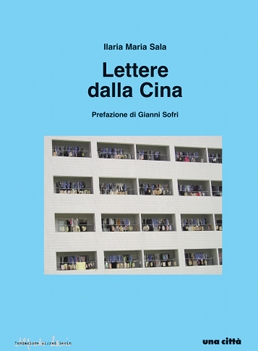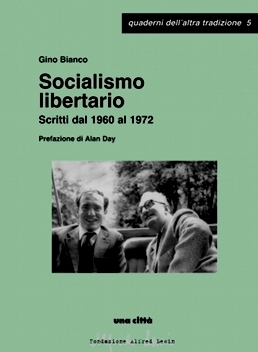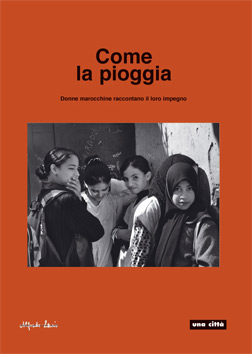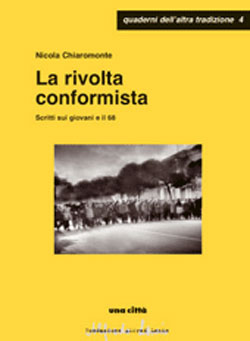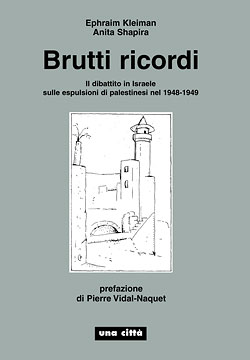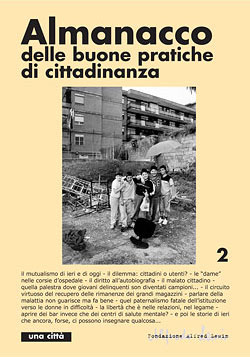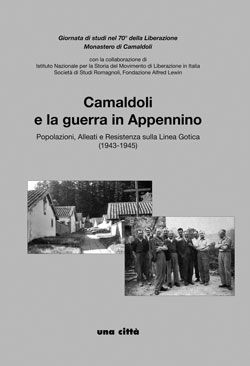La lezione della Bosnia
cosa sta succedendo

Una Città n° 308 / 2025 marzo
Intervista a Konstanty Gebert
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
LA LEZIONE DELLA BOSNIA
La Polonia, più di altri paesi europei, è oggi in allerta per l’esito della guerra in Ucraina dopo il voltafaccia di Trump; un’Unione europea che ancora non ha trovato quell’unità e forza che i tempi richiederebbero; l’opzione pacifista e la tragica lezione della Bosnia; perché non si può accettare una pace ingiusta e cosa fare affinché davanti a un aggressore non ci resti come unica opzione quella di chiedere: “Perché?”. Intervista a Konstanty Gebert.
Konstanty Gebert è scrittore e giornalista per il quotidiano polacco “Gazeta Wyborcza”. È stato corrispondente di guerra nei Balcani e advisor del Special Rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori dell’ex Yugoslavia Tadeusz Mazowiecki. È stato giornalista clandestino di Solidarnosc, partecipa a think tank europei ed è attivo sulle questioni ebraiche.
Trump ha sparigliato le carte sul piano nazionale e internazionale...
L’arrivo di Trump ha posto fine a quella che se vogliamo era una aberrazione durata ottant’anni, cioè all’idea di un mondo regolato non con la forza e la potenza, ma in base a un sistema di leggi internazionali rispettate dagli attori principali, volontariamente. Il sistema internazionale sorto dopo la Seconda guerra era dovuto soprattutto al fatto che la più grande potenza aveva preso l’impegno di rispettare queste leggi. Nella pratica non era sempre così, però le varie dichiarazioni non erano mai state ritirate e infatti, nella maggior parte dei casi, gli Stati Uniti, casomai sotto pressione, si sottoponevano alle regole del diritto internazionale e noi tutti credevamo che questo sistema fosse destinato a durare. Invece a un certo punto è arrivato Trump e ha detto: “Me ne frego”, e con questo ha messo fine a ottant’anni di storia del Dopoguerra, riportandoci indietro all’Ottocento, al lungo Ottocento dalla Rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale, quando le potenze si comportavano secondo la loro potenza e volontà.
Si può dire che in gran parte questi ottant’anni sono stati un periodo segnato anche da un certo livello di ipocrisia visto che anche i paesi che dichiaravano di rispettare la legge internazionale, in primis gli Stati Uniti, spesso la violavano. Questo è vero, e tuttavia non la negavano.
Come ha detto La Rochefoucault, l’ipocrisia è l’omaggio che il vizio rende alla virtù: cioè io faccio il male, ma proprio perché ne sono consapevole fingo di fare il bene. Questo, se vogliamo, è comunque un passo avanti perché crea l’aspettativa per cui, se non intervengono circostanze straordinarie, noi ci comporteremo secondo le regole. Ecco, questo non vale più.
E adesso cosa succede? L’Unione europea è in subbuglio, in particolare la Polonia, data la sua storia passata. Qual è il clima nel paese?
C’è una diffusa paura della guerra; è un tema presente nelle conversazioni quotidiane. Per una parte della classe media la soluzione è diventata comprare casa in Portogallo, nella speranza che, prima che i russi arrivino laggiù, si guadagnino un paio d’anni di vita al sicuro e poi si vedrà.
Nella classe politica c’è invece una profonda spaccatura tra la coalizione liberale attualmente al potere e il partito populista autoritario “Legge e Giustizia”, che ha governato il paese negli otto anni precedenti. La coalizione liberale dice che, visto che non ci si può più fidare degli Stati Uniti, bisogna rifare un’Europa più forte, capace di far fronte alla Russia. Che sia una prospettiva realistica o meno è un altro discorso, ma questa è una posizione abbastanza salda e Donald Tusk, il primo ministro ed ex presidente del Consiglio europeo, è tra i principali promotori di questa idea nei vertici europei.
Invece, “Legge e Giustizia” sostiene che bisogna mantenere lo stretto rapporto con Trump e di conseguenza, ovviamente, cambiare governo, perché quello attuale non gode della sua fiducia. Ora, è assai probabile che il governo attuale non abbia la fiducia del presidente americano, il che non lo distingue da tanti altri governi nel mondo, ma l’idea che si possa riporre fiducia in Trump, nella prospettiva di abbandonare la nostra sovranità e diventare un paese vassallo degli Stati Uniti, in cambio di promesse che nessuno garantisce saranno rispettate... Oppure, ripeto, si può scappare in Portogallo. Ma questa non è evidentemente una soluzione praticabile per 38 milioni di polacchi -e non lo è neanche per il Portogallo.
In alternativa si tratterebbe di provare a contrastare la prepotenza russa, ma anche quella americana, il che richiederebbe un’Europa molto più forte e unita, cosa che io non vedo all’orizzonte. Cioè non vedo nessuno degli stati europei, Polonia inclusa, pronto ad abbandonare l’idea di una sovranità nazionale in quest’ambito. Ma senza questo passaggio non ci potrà essere una forza armata europea e senza una forza armata europea non vedo un modo credibile di contrastare la minaccia russa.
Quindi la mia paura è che andremo verso un periodo in cui i russi, avendo conquistato l’Ucraina con l’appoggio americano, continueranno a fare pressioni. Putin non nasconde nemmeno che il suo obiettivo è di riportare la situazione geopolitica a quella pre 1989. Io non temo tanto i carri armati russi a Varsavia; la guerra è costosa e anche se Putin vincesse, dovrebbe pagare un prezzo che probabilmente preferirebbe evitare. Ma non serve mandare i carri armati. Basta che l’ambasciatore russo dica che c’è un oligarca russo che vuole comprare l’industria petrolchimica polacca: “Confido che non ci saranno ostacoli all’operazione. Sennò andate pure avanti così, avete l’articolo 5, giusto?”.
In Polonia ci siamo già passati, abbiamo già testato l’idea di resistere militarmente facendo affidamento sulle alleanze internazionali. Era il 1939 e ci è costato sei milioni di morti e la metà del paese. Nessun governo polacco ripeterà quella mossa e questo lo sanno tutti; lo sa Putin e lo sa l’opinione pubblica polacca.
Se l’Europa assumesse una posizione molto ferma, ma sul serio, allora la Polonia sarebbe in grado di assumersi le sue responsabilità, ma senza un’Europa politicamente unita, questa rimane una pura finzione e a questo punto quello che possiamo aspettarci è una capitolazione, casomai lenta, diciamo una capitolazione “di velluto”.
L’Europa un poco però ha reagito… Forse con la Gran Bretagna, il Canada, potrebbe emergere un’altra configurazione politica, più ampia, in grado di resistere. Cosa ne pensi?
Se uno viene buttato in acqua ha due opzioni: nuotare o annegare. Fare dei movimenti scomposti e scoordinati pur di fare qualcosa non ti salva la vita. Se non sai nuotare, muori.
È bene che l’Europa stia reagendo; è vero che probabilmente abbiamo ancora il tempo di imparare a nuotare, ma per questo serve una volontà politica di unificazione che io non vedo. Io sono molto contento del fatto che l’Europa non capitoli così, senza provare a fare qualcosa, ma sforzarsi non basta.
Quando dici che non sappiamo nuotare, intendi che non sappiamo metterci assieme rinunciando a parte della nostra sovranità, o intendi anche che non sappiamo più fare la guerra. Dopo tanti anni qualcuno dice che è come se ci fosse stato un mutamento antropologico; si è sentito perfino dire che una pace ingiusta è preferibile alla guerra.
Quel sentimento è sempre esistito in Europa. Non so se ricordate il famoso voto della Oxford Union Society nel 1933. L’Oxford Union Society era un’organizzazione degli studenti di Oxford, l’emblema della classe privilegiata britannica. Ebbene, in quella sede si votò a immensa maggioranza che in nessuna circostanza sarebbero stati disposti a combattere e a morire per il paese: “That this House will under no circumstances fight for its King and country”.
La maggior parte dell’Europa non ha conosciuto la guerra, però l’Ucraina la conosce, la Jugoslavia pure e ottant’anni sono un secondo nella storia della specie umana. Se l’umanità avesse dimenticato come fare la guerra, se questo fosse un sentimento universale, dovrebbe includere anche l’Ucraina, la Russia, gli Stati Uniti, Israele, i palestinesi, l’Etiopia, il Congo. eccetera. Empiricamente direi che non è vero. Gli europei occidentali di oggi non hanno fatto la guerra, ma è una cosa che si impara molto velocemente. Il vero punto è la volontà politica e qui si apre un dibattito che esiste da sempre, se sia meglio combattere o capitolare; non è un’alternativa nuova. Un’affermazione apparentemente ragionevole sostiene che se si capitola può rimanere uno spazio per negoziare e potrebbe non andare così male, invece se scoppia una guerra si muore. Questo è sempre un calcolo sbagliato perché con la capitolazione in realtà si abdica alla possibilità di influenzare il proprio avvenire. Chiedetelo ai danesi se vale la pena fare un compromesso con l’aggressore. Nel 1940 hanno accettato di fare un compromesso con i tedeschi. Nei primi tre anni si poteva pensare che ci avessero visto giusto. Però a un certo punto è stato chiesto loro di abbandonare gli ebrei. Loro non hanno accettato perché hanno capito che una volta accettato di pagare quel prezzo all’aggressore, la volta successiva sarebbero state pretese altre vittime da sacrificare. L’esperienza danese è una lezione rispetto alla logica della capitolazione.
E a proposito di questo, quale sarebbe la via più giusta oggi per sostenere l’Ucraina?
La scelta giusta sarebbe di sostenere l’Ucraina con tutte le capacità militari ed economiche a nostra disposizione; escluso l’invio di soldati perché su questo non c’è sostegno politico in Europa. A ogni modo l’Ucraina, più che soldati, in questo momento chiede armi e sostegno politico.
Bisognerebbe sostenere l’Ucraina per una ragione molto semplice: loro stanno morendo per noi. Quindi non si tratta nemmeno di un atto di solidarietà internazionale, ma di egoismo illuminato.
Ora tutto questo avrebbe funzionato se ci fosse stata una unità dell’Occidente, che evidentemente non c’è. È chiaro che gli Stati Uniti di Trump si sentono molto più vicini alla Russia di Putin che non all’Ucraina e quindi all’Europa.
Ora, l’Europa ha il potenziale militare e economico per sostenere l’Ucraina contro la Russia, ma non contro la Russia e gli Stati Uniti. Quindi l’obiettivo immediato è dare agli ucraini un tale aiuto che quando arriverà il momento di fare la pace o di cessare la guerra, loro potranno negoziare migliori condizioni.
In secondo luogo, bisognerebbe considerare che noi siamo potenzialmente i prossimi nella lista d’attesa, quindi occorre un esercito europeo, il che significa un governo europeo, che oggi però nessuno vuole. Il fatto è che, come nella metafora del nuoto, non basta fare grandi gesti con le mani e i piedi, bisogna coordinarli per sopravvivere. Noi questo ancora non lo sappiamo fare.
La prospettiva di un riarmo della Germania è una novità che sta inquietando molti, anche rispetto all’ipotesi di un paese dove in un prossimo futuro vincesse l’Afd. Tu come la vedi?
Io non mi fido della Germania come non mi fido della Polonia. Io voglio un esercito polacco forte, però temo che se rivincesse il partito “Legge e Giustizia”, quell’esercito polacco forte potrebbe servire a fare delle rivendicazioni nazionaliste contro i nostri vicini. Mi immagino molto bene una Germania governata dall’Afd, sostenuta da Putin, che comincia a rivendicare, per esempio, territori tedeschi in Polonia.
Questo non è inimmaginabile, però evitare di proteggersi contro una minaccia reale perché abbiamo paura di una minaccia potenziale non mi sembra sensato. Con un esercito polacco forte, mi sentirei più protetto, anche se posso ben capire che i paesi vicini, conoscendo la storia, potrebbero essere preoccupati da questa evoluzione. Purtroppo non possiamo permetterci il lusso di scegliere soluzioni perfette. Dobbiamo accontentarci delle meno dannose.
Non hai citato l’opzione pacifista...
Il pacifismo in principio è la strada migliore, purché sia condivisa. Io ho imparato questa lezione a Sarajevo, che era una città pacifista. Uno dei tratti caratteristici della Bosnia era proprio il suo essere un paese pacifico: i bosniaci che facevano il servizio militare nell’esercito iugoslavo raramente facevano carriera, perché non gli interessava. Tant’è che la decisione, se vuoi geniale, del generale Divjak, all’epoca comandante della difesa cittadina, fu di aprire le prigioni, perché là c’era gente che sapeva sparare. Sono stati loro all’inizio a difendere Sarajevo nell’aprile e maggio 1992, prima che si creasse un nuovo esercito bosniaco. Gli amici sarajevesi erano disperati e totalmente incapaci di difendersi. Quando sono tornato da Sarajevo ho detto ai miei figli che dovevano imparare a sparare. Ovviamente si sono tutti rifiutati; soltanto anni dopo ho saputo che avevano in effetti imparato, ma non me l’avevano detto per non darmi soddisfazione. Se arriva il momento di decidere se sparare o no, io ovviamente rispetto che si decida di non farlo, ma dev’essere appunto una decisione e non una scelta dettata dal fatto che non si è capaci di difendersi.
Nel nostro paese l’eventualità di un’aggressione viene percepita come molto remota, se non inverosimile.
L’Italia è un paese felice perché legittimamente non si sente direttamente coinvolto, perché non è vero che siamo agli anni Trenta del secolo scorso. La situazione è diversa. L’aggressore non ha la volontà strategica di mandare carri armati russi a Roma o a Madrid. Mi immagino che anche dal punto di vista russo, un’Italia che non si compatta attorno all’idea di dover combattere per difendere la propria indipendenza risulti senz’altro preferibile, perché è un paese con cui si può continuare a fare affari. Se invece le cose non vanno secondo i desideri di Mosca, la Russia ha l’argomento della forza. Può addirittura dichiararsi pacifista in principio: “Io non voglio fare la guerra. Non costringetemi a farla”. Se l’Ucraina avesse concesso alla Russia i territori che questa legittimamente rivendica, non ci sarebbe stata la guerra. Questa alla fine è la versione di Putin e oggi anche di Trump.
Ci troviamo in una situazione in cui il pacifismo trova di fatto alleati tra i fautori della guerra. Comunque è comprensibile che le conseguenze di quanto sta avvenendo, per quanto evidenti, non influenzino la situazione politica e il dibattito in un paese che si sente ancora in salvo.
A Sarajevo vivevo nella casa dei genitori di un mio amico. Loro mi avevano raccontato come avevano visto arrivare la guerra in casa. Prima c’era stata la Slovenia, che però per i bosniaci era quasi un paese straniero. Tra l’altro in quel caso il conflitto si era esaurito in una settimana. Poi era scoppiata la guerra in Croazia; una guerra vera questa volta, ma tutti consideravano i croati, e anche i serbi, dei pazzi e quindi… Poi però hanno iniziato a sparare a Grbavica, “a sei chilometri da casa nostra”, mi spiegava la mamma del mio amico. “Alla fine è arrivato un carro armato serbo lì sulla collina che si vedeva della finestra e ha sparato un proiettile nel nostro salotto”.
L’episodio che secondo me ben rappresenta quel modo di pensare è il discorso del presidente Izetbegovic alla vigilia della guerra alla Camera dei deputati a Sarajevo, quando disse: “Cittadini della Bosnia, potete dormire tranquilli, la guerra non ci sarà perché per fare la guerra bisogna essere in due. I serbi sanno che noi la guerra, non solo non la vogliamo, ma non possiamo farla perché non abbiamo le armi, quindi non ci sarà nessuna guerra”. Si sbagliava: ne basta uno per fare la guerra, soprattutto se l’altro dichiara di non avere armi per difendersi.
Se volete, l’Italia si trova nella situazione della Bosnia di Izetbegovic: la guerra non ci sarà perché noi non vogliamo e non possiamo farla, che vuol dire lasciare la decisione completamente nelle mani di un aggressore che ha già dimostrato che la guerra la vuole e sa farla. A me sembra un approccio suicida…
Se però nello schieramento dei volenterosi entrano anche la Turchia e la Cina…
Che dire? Affidarsi all’esercito dei dittatori per creare un mondo pacifico e libero mi sembra una pazzia. Prima di invitare i turchi in casa nostra, e l’Europa è casa nostra, io chiederei l’opinione dei curdi. Prima di invitare l’esercito cinese, io chiederei l’opinione degli uiguri.
L’idea che possiamo noleggiare degli eserciti per risolvere i problemi che noi non sappiamo risolvere e che il prezzo da pagare sia solo economico… Mah, mi sembra davvero l’idea di qualcuno che non conosce la storia, neanche quella del suo paese. Non funziona mai così. Ora, è vero che la Turchia sta diventando una potenza regionale e quindi va tenuta in considerazione quando si ragiona sulle grandi soluzioni per l’Ucraina o per il Medio Oriente, però...
Riguardo gli Stati Uniti, vedi un passaggio irreversibile o si può tornare indietro?
La svolta è ormai realtà. Il bluff del rispetto del diritto è stato svelato. Però Trump è stato eletto democraticamente, con una maggioranza dei voti. Non è impensabile che qualcuno lo assassini, ma questo significherebbe guerra civile e l’ultima volta che negli Stati Uniti è stata fatta una guerra civile è stata una cosa devastante. C’è quel recente film americano, “Civil war”, ambientato appunto nell’ambito di una guerra civile terribile. Se valga la pena di pagare l’altissimo prezzo di una guerra civile per un’America non trumpiana è una domanda a cui è difficile rispondere e comunque è una decisione che spetta agli americani. Comunque se anche Trump uscisse di scena per un infarto o per un golpe non violento, rimane il fatto che la fiducia nell’idea di un consenso intorno alla legge internazionale è distrutta, così come la fiducia nella democrazia americana e purtroppo non vedo all’orizzonte cosa potrebbe rimpiazzare queste due idee su cui si fondava l’ordine internazionale dopo la Seconda guerra mondiale.
L’arrivo sulla scena di Trump sta avendo un impatto anche sul Medio Oriente. Come vedi la situazione?
Disastrosa. Intanto il conflitto con Hamas e anche con l’Iran non sono risolti e non sono risolvibili militarmente. Lo vediamo bene a Gaza: Netanyahu ha lanciato una seconda offensiva contro Gaza e non si capisce quale sia lo scopo militare. Se Hamas non è stato distrutto dalla prima guerra di Gaza non so che cosa possiamo fare di più per distruggerlo, a parte ammazzare tutti i maschi.
Quindi militarmente questa guerra non ha senso e allontana una soluzione politica. Abbiamo una sceneggiatura fallimentare e distruttiva su entrambi i versanti e in più stiamo assistendo al pericolo, reale, della fine della democrazia in Israele.
Nei prossimi giorni ci sarà il voto della Knesset su questa nuova legge relativa alla nomina dei giudici; se passa, i giudici saranno sottoposti all’esecutivo. Netanyahu giustifica l’operazione dicendo che così si daranno pari poteri al governo e all’opposizione. Ma l’indipendenza giudiziaria non significa che non solo il governo, ma anche l’opposizione, può influenzare la nomina dei giudici! Noi vogliamo ridurre l’influenza sia dell’opposizione che del governo!
Abbiamo già una situazione nella quale la Corte suprema ha ordinato al governo di sospendere le deliberazioni sul licenziamento della procuratrice generale dicendo che, senza consultare i vari enti legali, il governo non può procedere. Il governo ha risposto che se ne frega di questa decisione della Corte e che anzi questa decisione è la prova di un tentativo di golpe della Corte contro il governo.
Ci sono delle assonanze con la situazione americana. Anche Israele fin dall’inizio era lacerata da violentissimi conflitti interni, che però rimanevano all’interno di una cornice di consenso sul fatto che non si attaccano le basi del sistema politico. Oggi abbiamo una élite politica, minoritaria secondo i sondaggi, che ha deciso di abbandonare quel principio. Se il rischio è di perdere il potere, questo legittima anche un attacco contro il sistema istituzionale. Che è poi l’idea trumpiana e che potrebbe diventare l’idea dell’Afd qualora andasse al governo in Germania.
In più in Israele è in atto un paradosso. All’inizio del processo per corruzione e frode contro Netanyahu, è uscito un commento provocatorio in un giornale saudita in cui in sostanza si diceva: “Un Israele dove l’esecutivo è corrotto e ignora l’autonomia del potere giudiziario, che si serve dell’isteria nazionalista e religiosa come arma politica; beh, con un paese del genere possiamo convivere, non è tanto diverso da noi”. Si può addirittura immaginare che tra cent’anni gli storici scriveranno che l’orribile periodo di dittatura etnico-religiosa e aggressiva è stato un momento decisivo per l’assimilazione di Israele nel Medio Oriente, e quindi una sorta di strumento fondamentale per la pace!
Uno dei motivi per il quale i popoli arabi mostrano tanta solidarietà con i palestinesi non è la simpatia per questi ultimi, che in realtà non sono così amati nel mondo arabo; molti arabi li vedono più come ebrei che arabi (questa è una digressione dentro una digressione, ma si tratta di una visione legittima; i palestinesi tendono ad assomigliare più agli israeliani che agli altri arabi, così come gli israeliani somigliano più ai palestinesi che ad altri ebrei; è un processo naturale: vivere insieme porta, inevitabilmente, a una reciproca assimilazione). Ma allora perché questa grande solidarietà? Perché nei palestinesi i popoli arabi vedono un altro popolo che si ribella contro un potere da loro non scelto e che agisce contro i loro interessi; questa è infatti la situazione di ogni popolo arabo, che sia libanese, siriano o anche saudita; di qui l’identificazione con i palestinesi che lottano contro un tale potere che, per di più, non è arabo.
Io oggi non vedo un fattore che spinga nella direzione opposta di quella di una mancata democrazia e della guerra. Forse lo era l’America di Biden. L’Europa a parole afferma di esserlo, ma non lo è: non abbiamo la sufficiente influenza su alcuna delle parti in conflitto. Rimane l’interesse egoista dei sauditi che preferiscono un Medio Oriente senza guerra, ma sono pronti a pagare qualsiasi prezzo soprattutto se a spese della libertà e sicurezza degli altri.
Siamo quindi entrati in una fase di arretramento della democrazia su scala globale...
La democrazia è innaturale. La democrazia è anti entropica. La tendenza naturale dell’universo fisico è verso un aumento dell’entropia, del caos e tutte le strutture che vanno nella direzione opposta, necessitano di un apporto energetico, devono essere mantenute da una forza esterna. Lo stesso si può dire della democrazia. La democrazia significa che la mia voce ha valore, e lo ha pure la tua, anche se le nostre opinioni sono opposte.
Ecco, questa non sembra un’idea naturale. Ogni successo della democrazia -ce ne sono stati tanti- va considerato una meraviglia da proteggere e di cui godere.
Albie Sachs, grandissimo militante anti apartheid che ho conosciuto a Gaza nell’ambito di un programma per una transizione pacifica, diceva sempre: “If you fail, try again, fail better”. Questa idea del “fail better”, del “fallisci meglio” è fondamentale per ogni democratico. Sappiamo che andremo incontro a delle sconfitte, facciamo in modo che queste sconfitte siano comunque “migliori”.
Vista questa situazione, pensi che altri paesi non occidentali potranno acquisire un ruolo in prospettiva?
Io ho sempre sostenuto che l’influenza internazionale di un paese dipende dalla sua influenza interna. La popolarità e l’influenza statunitense non era dovuta solo al potere militare ed economico, ma al fatto che la democrazia americana era impegnata per la difesa dei diritti umani e dava prova di poter migliorare e questo forniva all’America un’autorità non soltanto morale ma pratica.
È chiaro che la lotta contro il razzismo negli Stati Uniti non è finita, ma se pensiamo all’Africa del Sud, vediamo che non ha nessuna credibilità interna. E, sul piano internazionale, l’alleanza con l’Iran e la Russia inibiscono qualsiasi ruolo quale portavoce della giustizia e del progresso. La Nigeria ha provato a risolvere il problema del Biafra anche con metodi genocidari e hanno fallito; ora stanno provando con altri mezzi e questo è già un passo avanti. Il Brasile è praticamente un continente, come l’India... Comunque oggi la domanda non è se questi paesi avranno un’influenza sulla scena internazionale ma quale sarà il mondo influenzato da questi paesi.
Il primato europeo è in declino, mentre quello americano sembra avviato verso un suicidio. Se vogliamo scongiurare una futura egemonia cinese, la nostra speranza restano gli altri paesi. Quindi è indubbio che saranno questi altri paesi a influenzare il mondo; non è chiaro se lo faranno meglio di noi.
Ci lasci con un certo pessimismo...
Io spero di morire di cause naturali prima di dover decidere se sparare, però io lo so fare e quindi sono consapevole di avere questa opzione.
Durante la guerra in Bosnia, di fronte all’ospedale Kosevo c’erano sempre dei giornalisti perché era lì che portavano le vittime; un giorno, per fare un servizio, hanno seguito un padre che portava la sua figlioletta colpita mortalmente da uno sniper, un cecchino (lui ancora non sapeva che stava morendo), e un giornalista gli ha chiesto: “Che cosa faresti se incontrassi il cecchino che ha colpito tua figlia?”, e quell’uomo, coperto del sangue della bambina, ha risposto: ‘Gli offrirei un caffè e gli chiederei: perché?’”.
Un amico di Sarajevo aveva registrato questa sequenza e mi raccontava che ogni volta che c’era l’elettricità la riguardava “per ricordarmi perché io sparo”, mi aveva spiegato. Ecco, io dico che non possiamo trovarci in una situazione dove l’unica cosa che possiamo fare è chiedere: “Perché?”.
Sapete, da noi si dice: “L’ottimista dice che viviamo nel migliore mondo possibile; il pessimista teme che l’ottimista abbia ragione”.
(a cura di Bettina Foa e Barbara Bertoncin)
Trump ha sparigliato le carte sul piano nazionale e internazionale...
L’arrivo di Trump ha posto fine a quella che se vogliamo era una aberrazione durata ottant’anni, cioè all’idea di un mondo regolato non con la forza e la potenza, ma in base a un sistema di leggi internazionali rispettate dagli attori principali, volontariamente. Il sistema internazionale sorto dopo la Seconda guerra era dovuto soprattutto al fatto che la più grande potenza aveva preso l’impegno di rispettare queste leggi. Nella pratica non era sempre così, però le varie dichiarazioni non erano mai state ritirate e infatti, nella maggior parte dei casi, gli Stati Uniti, casomai sotto pressione, si sottoponevano alle regole del diritto internazionale e noi tutti credevamo che questo sistema fosse destinato a durare. Invece a un certo punto è arrivato Trump e ha detto: “Me ne frego”, e con questo ha messo fine a ottant’anni di storia del Dopoguerra, riportandoci indietro all’Ottocento, al lungo Ottocento dalla Rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale, quando le potenze si comportavano secondo la loro potenza e volontà.
Si può dire che in gran parte questi ottant’anni sono stati un periodo segnato anche da un certo livello di ipocrisia visto che anche i paesi che dichiaravano di rispettare la legge internazionale, in primis gli Stati Uniti, spesso la violavano. Questo è vero, e tuttavia non la negavano.
Come ha detto La Rochefoucault, l’ipocrisia è l’omaggio che il vizio rende alla virtù: cioè io faccio il male, ma proprio perché ne sono consapevole fingo di fare il bene. Questo, se vogliamo, è comunque un passo avanti perché crea l’aspettativa per cui, se non intervengono circostanze straordinarie, noi ci comporteremo secondo le regole. Ecco, questo non vale più.
E adesso cosa succede? L’Unione europea è in subbuglio, in particolare la Polonia, data la sua storia passata. Qual è il clima nel paese?
C’è una diffusa paura della guerra; è un tema presente nelle conversazioni quotidiane. Per una parte della classe media la soluzione è diventata comprare casa in Portogallo, nella speranza che, prima che i russi arrivino laggiù, si guadagnino un paio d’anni di vita al sicuro e poi si vedrà.
Nella classe politica c’è invece una profonda spaccatura tra la coalizione liberale attualmente al potere e il partito populista autoritario “Legge e Giustizia”, che ha governato il paese negli otto anni precedenti. La coalizione liberale dice che, visto che non ci si può più fidare degli Stati Uniti, bisogna rifare un’Europa più forte, capace di far fronte alla Russia. Che sia una prospettiva realistica o meno è un altro discorso, ma questa è una posizione abbastanza salda e Donald Tusk, il primo ministro ed ex presidente del Consiglio europeo, è tra i principali promotori di questa idea nei vertici europei.
Invece, “Legge e Giustizia” sostiene che bisogna mantenere lo stretto rapporto con Trump e di conseguenza, ovviamente, cambiare governo, perché quello attuale non gode della sua fiducia. Ora, è assai probabile che il governo attuale non abbia la fiducia del presidente americano, il che non lo distingue da tanti altri governi nel mondo, ma l’idea che si possa riporre fiducia in Trump, nella prospettiva di abbandonare la nostra sovranità e diventare un paese vassallo degli Stati Uniti, in cambio di promesse che nessuno garantisce saranno rispettate... Oppure, ripeto, si può scappare in Portogallo. Ma questa non è evidentemente una soluzione praticabile per 38 milioni di polacchi -e non lo è neanche per il Portogallo.
In alternativa si tratterebbe di provare a contrastare la prepotenza russa, ma anche quella americana, il che richiederebbe un’Europa molto più forte e unita, cosa che io non vedo all’orizzonte. Cioè non vedo nessuno degli stati europei, Polonia inclusa, pronto ad abbandonare l’idea di una sovranità nazionale in quest’ambito. Ma senza questo passaggio non ci potrà essere una forza armata europea e senza una forza armata europea non vedo un modo credibile di contrastare la minaccia russa.
Quindi la mia paura è che andremo verso un periodo in cui i russi, avendo conquistato l’Ucraina con l’appoggio americano, continueranno a fare pressioni. Putin non nasconde nemmeno che il suo obiettivo è di riportare la situazione geopolitica a quella pre 1989. Io non temo tanto i carri armati russi a Varsavia; la guerra è costosa e anche se Putin vincesse, dovrebbe pagare un prezzo che probabilmente preferirebbe evitare. Ma non serve mandare i carri armati. Basta che l’ambasciatore russo dica che c’è un oligarca russo che vuole comprare l’industria petrolchimica polacca: “Confido che non ci saranno ostacoli all’operazione. Sennò andate pure avanti così, avete l’articolo 5, giusto?”.
In Polonia ci siamo già passati, abbiamo già testato l’idea di resistere militarmente facendo affidamento sulle alleanze internazionali. Era il 1939 e ci è costato sei milioni di morti e la metà del paese. Nessun governo polacco ripeterà quella mossa e questo lo sanno tutti; lo sa Putin e lo sa l’opinione pubblica polacca.
Se l’Europa assumesse una posizione molto ferma, ma sul serio, allora la Polonia sarebbe in grado di assumersi le sue responsabilità, ma senza un’Europa politicamente unita, questa rimane una pura finzione e a questo punto quello che possiamo aspettarci è una capitolazione, casomai lenta, diciamo una capitolazione “di velluto”.
L’Europa un poco però ha reagito… Forse con la Gran Bretagna, il Canada, potrebbe emergere un’altra configurazione politica, più ampia, in grado di resistere. Cosa ne pensi?
Se uno viene buttato in acqua ha due opzioni: nuotare o annegare. Fare dei movimenti scomposti e scoordinati pur di fare qualcosa non ti salva la vita. Se non sai nuotare, muori.
È bene che l’Europa stia reagendo; è vero che probabilmente abbiamo ancora il tempo di imparare a nuotare, ma per questo serve una volontà politica di unificazione che io non vedo. Io sono molto contento del fatto che l’Europa non capitoli così, senza provare a fare qualcosa, ma sforzarsi non basta.
Quando dici che non sappiamo nuotare, intendi che non sappiamo metterci assieme rinunciando a parte della nostra sovranità, o intendi anche che non sappiamo più fare la guerra. Dopo tanti anni qualcuno dice che è come se ci fosse stato un mutamento antropologico; si è sentito perfino dire che una pace ingiusta è preferibile alla guerra.
Quel sentimento è sempre esistito in Europa. Non so se ricordate il famoso voto della Oxford Union Society nel 1933. L’Oxford Union Society era un’organizzazione degli studenti di Oxford, l’emblema della classe privilegiata britannica. Ebbene, in quella sede si votò a immensa maggioranza che in nessuna circostanza sarebbero stati disposti a combattere e a morire per il paese: “That this House will under no circumstances fight for its King and country”.
La maggior parte dell’Europa non ha conosciuto la guerra, però l’Ucraina la conosce, la Jugoslavia pure e ottant’anni sono un secondo nella storia della specie umana. Se l’umanità avesse dimenticato come fare la guerra, se questo fosse un sentimento universale, dovrebbe includere anche l’Ucraina, la Russia, gli Stati Uniti, Israele, i palestinesi, l’Etiopia, il Congo. eccetera. Empiricamente direi che non è vero. Gli europei occidentali di oggi non hanno fatto la guerra, ma è una cosa che si impara molto velocemente. Il vero punto è la volontà politica e qui si apre un dibattito che esiste da sempre, se sia meglio combattere o capitolare; non è un’alternativa nuova. Un’affermazione apparentemente ragionevole sostiene che se si capitola può rimanere uno spazio per negoziare e potrebbe non andare così male, invece se scoppia una guerra si muore. Questo è sempre un calcolo sbagliato perché con la capitolazione in realtà si abdica alla possibilità di influenzare il proprio avvenire. Chiedetelo ai danesi se vale la pena fare un compromesso con l’aggressore. Nel 1940 hanno accettato di fare un compromesso con i tedeschi. Nei primi tre anni si poteva pensare che ci avessero visto giusto. Però a un certo punto è stato chiesto loro di abbandonare gli ebrei. Loro non hanno accettato perché hanno capito che una volta accettato di pagare quel prezzo all’aggressore, la volta successiva sarebbero state pretese altre vittime da sacrificare. L’esperienza danese è una lezione rispetto alla logica della capitolazione.
E a proposito di questo, quale sarebbe la via più giusta oggi per sostenere l’Ucraina?
La scelta giusta sarebbe di sostenere l’Ucraina con tutte le capacità militari ed economiche a nostra disposizione; escluso l’invio di soldati perché su questo non c’è sostegno politico in Europa. A ogni modo l’Ucraina, più che soldati, in questo momento chiede armi e sostegno politico.
Bisognerebbe sostenere l’Ucraina per una ragione molto semplice: loro stanno morendo per noi. Quindi non si tratta nemmeno di un atto di solidarietà internazionale, ma di egoismo illuminato.
Ora tutto questo avrebbe funzionato se ci fosse stata una unità dell’Occidente, che evidentemente non c’è. È chiaro che gli Stati Uniti di Trump si sentono molto più vicini alla Russia di Putin che non all’Ucraina e quindi all’Europa.
Ora, l’Europa ha il potenziale militare e economico per sostenere l’Ucraina contro la Russia, ma non contro la Russia e gli Stati Uniti. Quindi l’obiettivo immediato è dare agli ucraini un tale aiuto che quando arriverà il momento di fare la pace o di cessare la guerra, loro potranno negoziare migliori condizioni.
In secondo luogo, bisognerebbe considerare che noi siamo potenzialmente i prossimi nella lista d’attesa, quindi occorre un esercito europeo, il che significa un governo europeo, che oggi però nessuno vuole. Il fatto è che, come nella metafora del nuoto, non basta fare grandi gesti con le mani e i piedi, bisogna coordinarli per sopravvivere. Noi questo ancora non lo sappiamo fare.
La prospettiva di un riarmo della Germania è una novità che sta inquietando molti, anche rispetto all’ipotesi di un paese dove in un prossimo futuro vincesse l’Afd. Tu come la vedi?
Io non mi fido della Germania come non mi fido della Polonia. Io voglio un esercito polacco forte, però temo che se rivincesse il partito “Legge e Giustizia”, quell’esercito polacco forte potrebbe servire a fare delle rivendicazioni nazionaliste contro i nostri vicini. Mi immagino molto bene una Germania governata dall’Afd, sostenuta da Putin, che comincia a rivendicare, per esempio, territori tedeschi in Polonia.
Questo non è inimmaginabile, però evitare di proteggersi contro una minaccia reale perché abbiamo paura di una minaccia potenziale non mi sembra sensato. Con un esercito polacco forte, mi sentirei più protetto, anche se posso ben capire che i paesi vicini, conoscendo la storia, potrebbero essere preoccupati da questa evoluzione. Purtroppo non possiamo permetterci il lusso di scegliere soluzioni perfette. Dobbiamo accontentarci delle meno dannose.
Non hai citato l’opzione pacifista...
Il pacifismo in principio è la strada migliore, purché sia condivisa. Io ho imparato questa lezione a Sarajevo, che era una città pacifista. Uno dei tratti caratteristici della Bosnia era proprio il suo essere un paese pacifico: i bosniaci che facevano il servizio militare nell’esercito iugoslavo raramente facevano carriera, perché non gli interessava. Tant’è che la decisione, se vuoi geniale, del generale Divjak, all’epoca comandante della difesa cittadina, fu di aprire le prigioni, perché là c’era gente che sapeva sparare. Sono stati loro all’inizio a difendere Sarajevo nell’aprile e maggio 1992, prima che si creasse un nuovo esercito bosniaco. Gli amici sarajevesi erano disperati e totalmente incapaci di difendersi. Quando sono tornato da Sarajevo ho detto ai miei figli che dovevano imparare a sparare. Ovviamente si sono tutti rifiutati; soltanto anni dopo ho saputo che avevano in effetti imparato, ma non me l’avevano detto per non darmi soddisfazione. Se arriva il momento di decidere se sparare o no, io ovviamente rispetto che si decida di non farlo, ma dev’essere appunto una decisione e non una scelta dettata dal fatto che non si è capaci di difendersi.
Nel nostro paese l’eventualità di un’aggressione viene percepita come molto remota, se non inverosimile.
L’Italia è un paese felice perché legittimamente non si sente direttamente coinvolto, perché non è vero che siamo agli anni Trenta del secolo scorso. La situazione è diversa. L’aggressore non ha la volontà strategica di mandare carri armati russi a Roma o a Madrid. Mi immagino che anche dal punto di vista russo, un’Italia che non si compatta attorno all’idea di dover combattere per difendere la propria indipendenza risulti senz’altro preferibile, perché è un paese con cui si può continuare a fare affari. Se invece le cose non vanno secondo i desideri di Mosca, la Russia ha l’argomento della forza. Può addirittura dichiararsi pacifista in principio: “Io non voglio fare la guerra. Non costringetemi a farla”. Se l’Ucraina avesse concesso alla Russia i territori che questa legittimamente rivendica, non ci sarebbe stata la guerra. Questa alla fine è la versione di Putin e oggi anche di Trump.
Ci troviamo in una situazione in cui il pacifismo trova di fatto alleati tra i fautori della guerra. Comunque è comprensibile che le conseguenze di quanto sta avvenendo, per quanto evidenti, non influenzino la situazione politica e il dibattito in un paese che si sente ancora in salvo.
A Sarajevo vivevo nella casa dei genitori di un mio amico. Loro mi avevano raccontato come avevano visto arrivare la guerra in casa. Prima c’era stata la Slovenia, che però per i bosniaci era quasi un paese straniero. Tra l’altro in quel caso il conflitto si era esaurito in una settimana. Poi era scoppiata la guerra in Croazia; una guerra vera questa volta, ma tutti consideravano i croati, e anche i serbi, dei pazzi e quindi… Poi però hanno iniziato a sparare a Grbavica, “a sei chilometri da casa nostra”, mi spiegava la mamma del mio amico. “Alla fine è arrivato un carro armato serbo lì sulla collina che si vedeva della finestra e ha sparato un proiettile nel nostro salotto”.
L’episodio che secondo me ben rappresenta quel modo di pensare è il discorso del presidente Izetbegovic alla vigilia della guerra alla Camera dei deputati a Sarajevo, quando disse: “Cittadini della Bosnia, potete dormire tranquilli, la guerra non ci sarà perché per fare la guerra bisogna essere in due. I serbi sanno che noi la guerra, non solo non la vogliamo, ma non possiamo farla perché non abbiamo le armi, quindi non ci sarà nessuna guerra”. Si sbagliava: ne basta uno per fare la guerra, soprattutto se l’altro dichiara di non avere armi per difendersi.
Se volete, l’Italia si trova nella situazione della Bosnia di Izetbegovic: la guerra non ci sarà perché noi non vogliamo e non possiamo farla, che vuol dire lasciare la decisione completamente nelle mani di un aggressore che ha già dimostrato che la guerra la vuole e sa farla. A me sembra un approccio suicida…
Se però nello schieramento dei volenterosi entrano anche la Turchia e la Cina…
Che dire? Affidarsi all’esercito dei dittatori per creare un mondo pacifico e libero mi sembra una pazzia. Prima di invitare i turchi in casa nostra, e l’Europa è casa nostra, io chiederei l’opinione dei curdi. Prima di invitare l’esercito cinese, io chiederei l’opinione degli uiguri.
L’idea che possiamo noleggiare degli eserciti per risolvere i problemi che noi non sappiamo risolvere e che il prezzo da pagare sia solo economico… Mah, mi sembra davvero l’idea di qualcuno che non conosce la storia, neanche quella del suo paese. Non funziona mai così. Ora, è vero che la Turchia sta diventando una potenza regionale e quindi va tenuta in considerazione quando si ragiona sulle grandi soluzioni per l’Ucraina o per il Medio Oriente, però...
Riguardo gli Stati Uniti, vedi un passaggio irreversibile o si può tornare indietro?
La svolta è ormai realtà. Il bluff del rispetto del diritto è stato svelato. Però Trump è stato eletto democraticamente, con una maggioranza dei voti. Non è impensabile che qualcuno lo assassini, ma questo significherebbe guerra civile e l’ultima volta che negli Stati Uniti è stata fatta una guerra civile è stata una cosa devastante. C’è quel recente film americano, “Civil war”, ambientato appunto nell’ambito di una guerra civile terribile. Se valga la pena di pagare l’altissimo prezzo di una guerra civile per un’America non trumpiana è una domanda a cui è difficile rispondere e comunque è una decisione che spetta agli americani. Comunque se anche Trump uscisse di scena per un infarto o per un golpe non violento, rimane il fatto che la fiducia nell’idea di un consenso intorno alla legge internazionale è distrutta, così come la fiducia nella democrazia americana e purtroppo non vedo all’orizzonte cosa potrebbe rimpiazzare queste due idee su cui si fondava l’ordine internazionale dopo la Seconda guerra mondiale.
L’arrivo sulla scena di Trump sta avendo un impatto anche sul Medio Oriente. Come vedi la situazione?
Disastrosa. Intanto il conflitto con Hamas e anche con l’Iran non sono risolti e non sono risolvibili militarmente. Lo vediamo bene a Gaza: Netanyahu ha lanciato una seconda offensiva contro Gaza e non si capisce quale sia lo scopo militare. Se Hamas non è stato distrutto dalla prima guerra di Gaza non so che cosa possiamo fare di più per distruggerlo, a parte ammazzare tutti i maschi.
Quindi militarmente questa guerra non ha senso e allontana una soluzione politica. Abbiamo una sceneggiatura fallimentare e distruttiva su entrambi i versanti e in più stiamo assistendo al pericolo, reale, della fine della democrazia in Israele.
Nei prossimi giorni ci sarà il voto della Knesset su questa nuova legge relativa alla nomina dei giudici; se passa, i giudici saranno sottoposti all’esecutivo. Netanyahu giustifica l’operazione dicendo che così si daranno pari poteri al governo e all’opposizione. Ma l’indipendenza giudiziaria non significa che non solo il governo, ma anche l’opposizione, può influenzare la nomina dei giudici! Noi vogliamo ridurre l’influenza sia dell’opposizione che del governo!
Abbiamo già una situazione nella quale la Corte suprema ha ordinato al governo di sospendere le deliberazioni sul licenziamento della procuratrice generale dicendo che, senza consultare i vari enti legali, il governo non può procedere. Il governo ha risposto che se ne frega di questa decisione della Corte e che anzi questa decisione è la prova di un tentativo di golpe della Corte contro il governo.
Ci sono delle assonanze con la situazione americana. Anche Israele fin dall’inizio era lacerata da violentissimi conflitti interni, che però rimanevano all’interno di una cornice di consenso sul fatto che non si attaccano le basi del sistema politico. Oggi abbiamo una élite politica, minoritaria secondo i sondaggi, che ha deciso di abbandonare quel principio. Se il rischio è di perdere il potere, questo legittima anche un attacco contro il sistema istituzionale. Che è poi l’idea trumpiana e che potrebbe diventare l’idea dell’Afd qualora andasse al governo in Germania.
In più in Israele è in atto un paradosso. All’inizio del processo per corruzione e frode contro Netanyahu, è uscito un commento provocatorio in un giornale saudita in cui in sostanza si diceva: “Un Israele dove l’esecutivo è corrotto e ignora l’autonomia del potere giudiziario, che si serve dell’isteria nazionalista e religiosa come arma politica; beh, con un paese del genere possiamo convivere, non è tanto diverso da noi”. Si può addirittura immaginare che tra cent’anni gli storici scriveranno che l’orribile periodo di dittatura etnico-religiosa e aggressiva è stato un momento decisivo per l’assimilazione di Israele nel Medio Oriente, e quindi una sorta di strumento fondamentale per la pace!
Uno dei motivi per il quale i popoli arabi mostrano tanta solidarietà con i palestinesi non è la simpatia per questi ultimi, che in realtà non sono così amati nel mondo arabo; molti arabi li vedono più come ebrei che arabi (questa è una digressione dentro una digressione, ma si tratta di una visione legittima; i palestinesi tendono ad assomigliare più agli israeliani che agli altri arabi, così come gli israeliani somigliano più ai palestinesi che ad altri ebrei; è un processo naturale: vivere insieme porta, inevitabilmente, a una reciproca assimilazione). Ma allora perché questa grande solidarietà? Perché nei palestinesi i popoli arabi vedono un altro popolo che si ribella contro un potere da loro non scelto e che agisce contro i loro interessi; questa è infatti la situazione di ogni popolo arabo, che sia libanese, siriano o anche saudita; di qui l’identificazione con i palestinesi che lottano contro un tale potere che, per di più, non è arabo.
Io oggi non vedo un fattore che spinga nella direzione opposta di quella di una mancata democrazia e della guerra. Forse lo era l’America di Biden. L’Europa a parole afferma di esserlo, ma non lo è: non abbiamo la sufficiente influenza su alcuna delle parti in conflitto. Rimane l’interesse egoista dei sauditi che preferiscono un Medio Oriente senza guerra, ma sono pronti a pagare qualsiasi prezzo soprattutto se a spese della libertà e sicurezza degli altri.
Siamo quindi entrati in una fase di arretramento della democrazia su scala globale...
La democrazia è innaturale. La democrazia è anti entropica. La tendenza naturale dell’universo fisico è verso un aumento dell’entropia, del caos e tutte le strutture che vanno nella direzione opposta, necessitano di un apporto energetico, devono essere mantenute da una forza esterna. Lo stesso si può dire della democrazia. La democrazia significa che la mia voce ha valore, e lo ha pure la tua, anche se le nostre opinioni sono opposte.
Ecco, questa non sembra un’idea naturale. Ogni successo della democrazia -ce ne sono stati tanti- va considerato una meraviglia da proteggere e di cui godere.
Albie Sachs, grandissimo militante anti apartheid che ho conosciuto a Gaza nell’ambito di un programma per una transizione pacifica, diceva sempre: “If you fail, try again, fail better”. Questa idea del “fail better”, del “fallisci meglio” è fondamentale per ogni democratico. Sappiamo che andremo incontro a delle sconfitte, facciamo in modo che queste sconfitte siano comunque “migliori”.
Vista questa situazione, pensi che altri paesi non occidentali potranno acquisire un ruolo in prospettiva?
Io ho sempre sostenuto che l’influenza internazionale di un paese dipende dalla sua influenza interna. La popolarità e l’influenza statunitense non era dovuta solo al potere militare ed economico, ma al fatto che la democrazia americana era impegnata per la difesa dei diritti umani e dava prova di poter migliorare e questo forniva all’America un’autorità non soltanto morale ma pratica.
È chiaro che la lotta contro il razzismo negli Stati Uniti non è finita, ma se pensiamo all’Africa del Sud, vediamo che non ha nessuna credibilità interna. E, sul piano internazionale, l’alleanza con l’Iran e la Russia inibiscono qualsiasi ruolo quale portavoce della giustizia e del progresso. La Nigeria ha provato a risolvere il problema del Biafra anche con metodi genocidari e hanno fallito; ora stanno provando con altri mezzi e questo è già un passo avanti. Il Brasile è praticamente un continente, come l’India... Comunque oggi la domanda non è se questi paesi avranno un’influenza sulla scena internazionale ma quale sarà il mondo influenzato da questi paesi.
Il primato europeo è in declino, mentre quello americano sembra avviato verso un suicidio. Se vogliamo scongiurare una futura egemonia cinese, la nostra speranza restano gli altri paesi. Quindi è indubbio che saranno questi altri paesi a influenzare il mondo; non è chiaro se lo faranno meglio di noi.
Ci lasci con un certo pessimismo...
Io spero di morire di cause naturali prima di dover decidere se sparare, però io lo so fare e quindi sono consapevole di avere questa opzione.
Durante la guerra in Bosnia, di fronte all’ospedale Kosevo c’erano sempre dei giornalisti perché era lì che portavano le vittime; un giorno, per fare un servizio, hanno seguito un padre che portava la sua figlioletta colpita mortalmente da uno sniper, un cecchino (lui ancora non sapeva che stava morendo), e un giornalista gli ha chiesto: “Che cosa faresti se incontrassi il cecchino che ha colpito tua figlia?”, e quell’uomo, coperto del sangue della bambina, ha risposto: ‘Gli offrirei un caffè e gli chiederei: perché?’”.
Un amico di Sarajevo aveva registrato questa sequenza e mi raccontava che ogni volta che c’era l’elettricità la riguardava “per ricordarmi perché io sparo”, mi aveva spiegato. Ecco, io dico che non possiamo trovarci in una situazione dove l’unica cosa che possiamo fare è chiedere: “Perché?”.
Sapete, da noi si dice: “L’ottimista dice che viviamo nel migliore mondo possibile; il pessimista teme che l’ottimista abbia ragione”.
(a cura di Bettina Foa e Barbara Bertoncin)
Archivio
PAURA E RABBIA
Una Città n° 273 / 2021 marzo
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Konstanty Gebert è scrittore e giornalista per il quotidiano polacco "Gazeta Wyborcza”. È stato corrispondente di guerra nei Balcani e advisor del Special Rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori dell’ex-Y...
Leggi di più
NESSUN ODIO E' ETERNO
Una Città n° 301 / 2024 aprile-maggio
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Konstanty Gebert è scrittore e giornalista per il quotidiano polacco “Gazeta Wyborcza”. È stato corrispondente di guerra nei Balcani e advisor del Special Rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori dell’ex ...
Leggi di più
UNA POLONIA COSI' BELLA...
Una Città n° 282 / 2022 marzo
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Realizzata da Barbara Bertoncin, Bettina Foa
Konstanty Gebert è scrittore e giornalista per il quotidiano polacco “Gazeta Wyborcza”. È stato corrispondente di guerra nei Balcani e advisor del Special Rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori dell’ex ...
Leggi di più
EDELMAN GLI RISPOSE...
Una Città n° 228 / 2016 febbraio
Realizzata da Bettina Foa
Realizzata da Bettina Foa
Konstanty Gebert è scrittore e giornalista per il quotidiano polacco "Gazeta Wyborcza”. È stato corrispondente di guerra nei Balcani e advisor del Special Rapporteur sulla situazione dei diritti umani nei territori dell’ex Yugoslavia Tadeusz Mazowiecki. È...
Leggi di più
LA PIAZZA DI LUBLINO
Una Città n° 120 / 2004 Aprile
Realizzata da Edi Rabini
Realizzata da Edi Rabini
Konstanty Gebert è noto sotto lo pseudonimo di Dawid Warszawski con cui ha sempre firmato i suoi scritti; è uno dei più noti giornalisti della stampa clandestina negli anni della legge marziale di Jaruzelski (i suoi scritti sono stati pubblicati anche in ...
Leggi di più