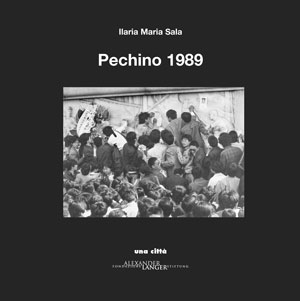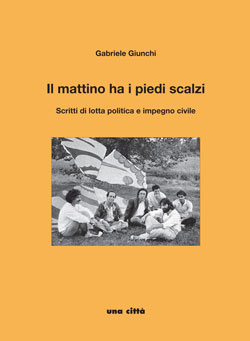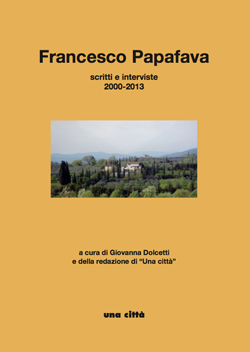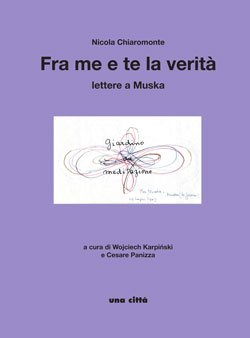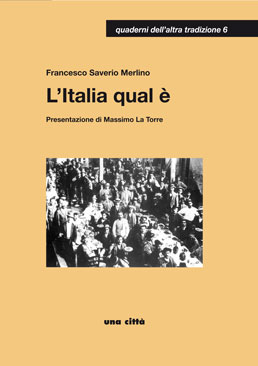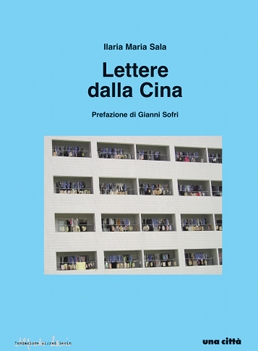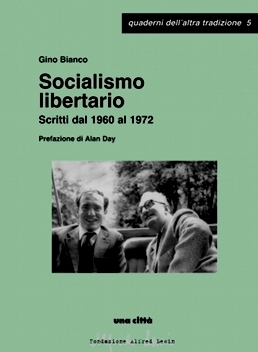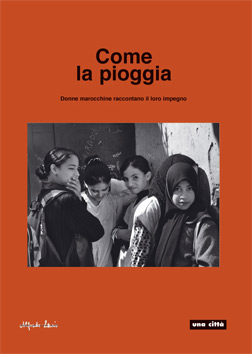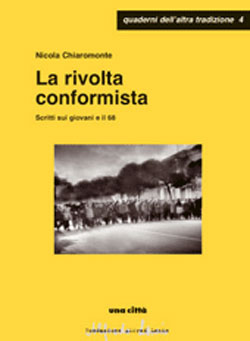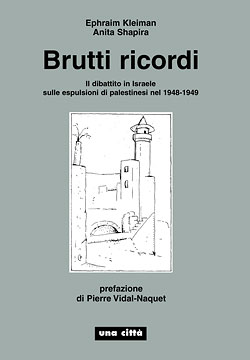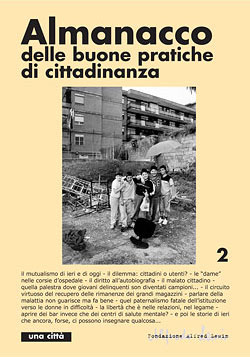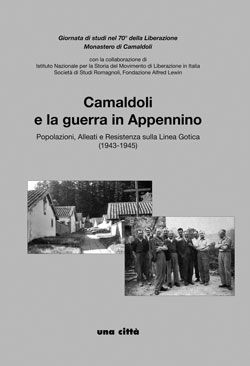I. Chi scrive ha letto questo libro non potendo prescindere, ovviamente, dalla propria età e storia. Appartengo a una generazione non toccata direttamente dalla guerra, ma nata dentro o a ridosso della guerra, una generazione che in Europa e nel mondo ha aperto gli occhi dappertutto contemporaneamente: nel Sessantotto. Il Sessantotto è stato un fenomeno mondiale -ha scritto Clemente Manenti- perché la Seconda guerra mondiale è stata in realtà la prima davvero globale. Tedeschi, francesi, polacchi, del Sessantotto erano tutti orfani, figli di orfani dal punto di vista civile: i giapponesi nati durante la Seconda guerra mondiale o nei sette anni dopo la guerra son tutti nati il 10 luglio 1945; i tedeschi loro coetanei sono nati l’8 maggio del ’45; gli italiani sono nati tutti l’8 settembre 1943.
Ora Luca Baldissara ha scritto un libro di storia della crisi del 1943 che dovrà essere incluso tra gli irrinunciabili, se vogliamo conoscere e capire la fine del fascismo, la Seconda guerra mondiale in Italia, l’inizio del secondo Novecento e le origini della Repubblica. Assieme a quelli di Battaglia, Zangrandi, Quazza, Pavone, ecc., Italia 1943. La guerra continua (Il Mulino, 2024) è un libro necessario, irrinunciabile.
Il suo titolo evoca la frase fatale di Vittorio Emanuele Orlando, recitata alla radio nelle orecchie incredule degli italiani dalla voce chioccia di Badoglio, dopo l’arresto di Mussolini il 25 luglio: affermazione assurda e falsa, tragica e farsesca.
Il 1943 fu infatti, prima d’ogni altra cosa, un anno sospeso -lo scrisse Bottai nel proprio Diario- tra farsa e tragedia. Il fascismo era nato dalla guerra, la Prima guerra mondiale, e dal conflitto del primo dopoguerra, per fare dell’“Italia di Vittorio Veneto” la protagonista di una politica aggressiva fondata su una serie di guerre di espansione, politica nazionalistica e imperialistica. Sebbene consapevole delle “mutate forme della guerra” sin dal 1914-18 e delle sue necessarie basi nell’economia industriale pianificata, nella tecnologia, nella mobilitazione totale della nazione, il regime non seppe però coinvolgere e dirigere le istituzioni statali nella programmazione delle nuove guerre, privilegiando una politica di mediazioni incardinata sul rapporto diretto tra Partito e poteri economici, né seppe ridurre l’arretratezza tecnica, la scarsità di materie prime e i contrasti tra interessi industriali, burocrazie e forze armate. Inadeguatezza e incapacità non furono esiti inevitabili, ma i risultati di una prassi consolidata di direzione politica del regime attraverso contraddizioni e compromessi sempre mediati dal Capo del regime. Nel 1940, nonostante i ritardi economici, tecnologici e nell’armamento (l’entrata in guerra era stata programmata per il 1942), l’azzardo bellico -la fine della “non belligeranza”- furono decise (si veda il Promemoria segreto mussoliniano del 31 marzo 1940) per non esser “tagliati fuori” dai vantaggi della “prevedibile” sconfitta anglo-francese, nell’illusione di sciogliere gli antichi nodi strategici del dominio su un Mediterraneo “controllato dagli altri” e dell’espansione nell’area adriatico-balcanica. Pareva una mossa furba, fu un disastro.
Con gli stessi intenti e gli stessi limiti di preparazione militare, l’Italia aveva iniziato la guerra già nel 1935 in Etiopia, proseguendola nel 1936 in Spagna e con la sigla del Protocollo dell’Asse con Berlino, e nel 1939 con l’invasione dell’Albania; nel 1940, però, questa guerra, in realtà in corso da un decennio, divenne furbescamente la cosiddetta guerra parallela italiana, ma si rivelò da subito praticabile solo in subordine al predominio economico e militare nazista e nel quadro della strategia hitleriana del Nuovo Ordine Europeo.
Emersero via via le incertezze strategiche, i piani tattici caotici e improvvisati, le indecisioni catastrofiche, prima nelle campagne di Francia, Egitto e Africa Orientale, infine nella più importante e tragica aggressione, quella alla Grecia: che fu anch’essa l’ennesima sconfitta, ancora una volta riparata dalla Wehrmacht, oltre che un errore strategico di destabilizzazione dei Balcani (dove l’Italia si troverà a governare Dalmazia, provincia di Lubiana, Montenegro, parte del Peloponneso e isole ionie), cioè i territori che costituivano il retroterra della prossima invasione dell’Unione Sovietica.
Il 1943 inizia dunque con un bilancio di numerose sconfitte e la “rotta” sul fronte del fiume Don. Inizia anche lo sbandamento del
...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!