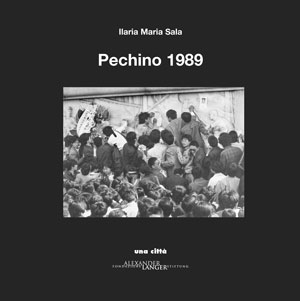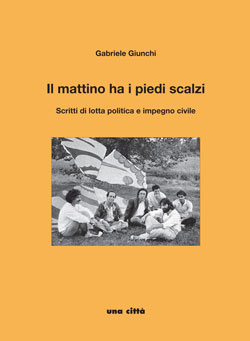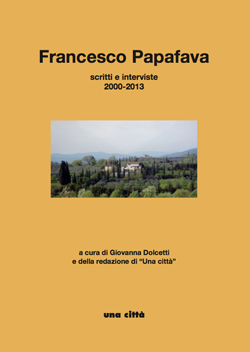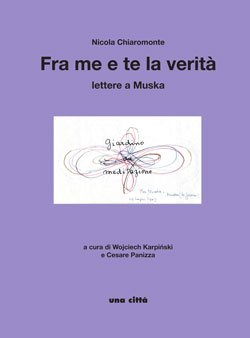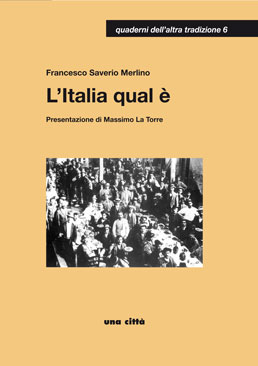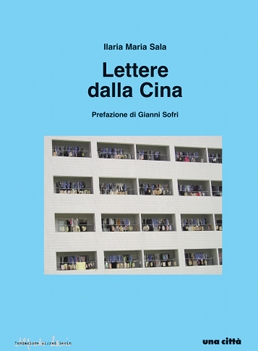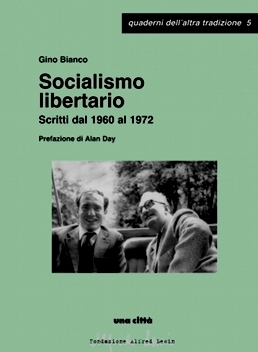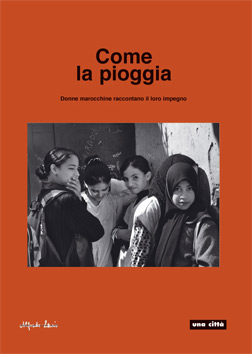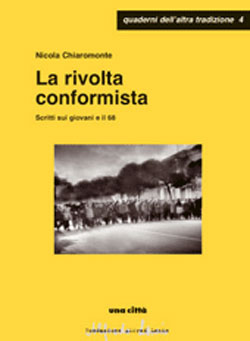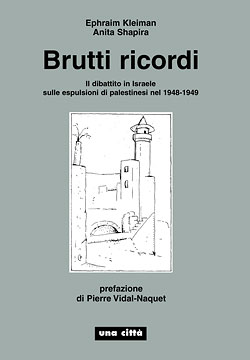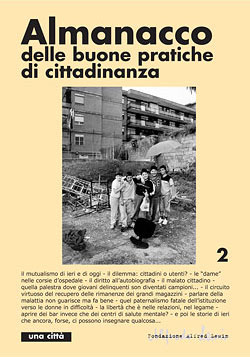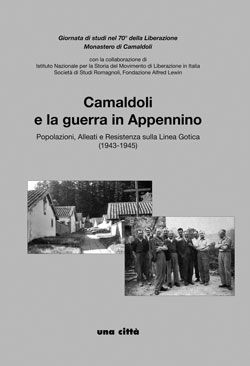Nella difficile situazione internazionale creata dagli accordi di Yalta, con la spartizione del mondo in zone di influenza gravide di tensioni internazionali, le parole che Altiero Spinelli aveva scritto nella primavera del ’44 rivolgendosi a Leo Valiani suonano profetiche: “Il nostro modello deve diventare ogni giorno di più -mutatis mutandis- Cavour e ogni giorno di meno Lenin, che invece è l’incubo di tutti i rivoluzionari di oggi”.
Così pensava Altiero Spinelli, al quale i cittadini europei e italiani devono molto per la sua intelligente iniziativa e per il coraggio con il quale ha lungamente sostenuto l’idea del Federalismo europeo, tanto che venne anche battezzato il “Parsifal del federalismo”, colui, cioè, pronto a guidare i giovani degli anni Quaranta e Cinquanta alla conquista del Graal europeo. Invitava, però, alla prudenza, contro il rischio di confondere gli intenti culturali con quelli politici, con movimenti e personaggi difficilmente in sintonia con i problemi e le ispirazioni di un organico federalismo europeo dopo le tensioni tragiche del secondo conflitto mondiale.
Predicava allora Spinelli di non evocare l’Europa di Carlo Magno, in quanto l’unione del continente compiuta da Carlo Magno nulla aveva da spartire con il federalismo. Dall’epoca di Carlo Magno il nostro continente si trascinava addosso il dramma di una ricerca di identità, mai trovata, di volta in volta avvistata in determinate concezioni teoretiche a carattere pseudo europeista, mentre il vero nodo del problema consisteva nella capacità di creare uno Stato comunitario, dotato dei poteri di sovrapporsi ai singoli membri dell’unione, senza ammettere la possibilità di scelte reversibili, senza postulare impossibili ritorni verso il nazionalismo.
Gli autori del Manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, compresero che l’avvenire del continente era legato al modo in cui si sarebbe condotto quello che ancora oggi si ama definire “il discorso sull’Europa” legato alla capacità di trasferire il suddetto discorso dal piano dell’elaborazione a quello delle applicazioni nella realtà.
C’è da rimanere costernati nel sentire la presidente Meloni compiere un’analisi deteriore e deformata del contenuto del Manifesto estrapolando frasi in modo sconnesso, come nel caso della critica alla proprietà privata, che con il marxismo non ha nulla da spartire. Certo, il Manifesto puntualizza che una Federazione seria non può contentarsi di dar vita a una Europa qualunque, ma che “la Rivoluzione europea per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista, dovrà ottenere l’emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane nella vita”, ma con stringente argomentare spiega ciò che la Meloni non ha capito: “Non si possono più lasciare ai privati le imprese che, svolgendo una attività necessariamente monopolistica, sono in condizioni di sfruttare la massa dei consumatori; ad esempio le industrie elettriche, le imprese che si vogliono mantenere in vita per ragioni di interesse collettivo ma che, per reggersi, hanno bisogno di dazi protettivi, sussidi, ordinazioni di favore (l’esempio più notevole di questo tipo di industria sono finora le industrie siderurgiche) e le imprese che per la grandezza dei capitali investiti e il numero degli opera ...[continua]
Esegui il login per visualizzare il testo completo.
Se sei un abbonato online, clicca qui accedere, oppure vai alla pagina Abbonamenti per acquistare l'abbonamento online.
Gli abbonati alla rivista hanno diritto all'abbonamento online gratuito!